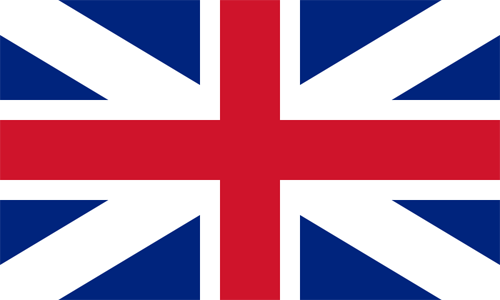La notizia della morte di Pino Daniele è arrivata in mattinata mentre ancora preparavo il caffè. É un giorno che non penso ad altro e che non sento parlare d’altro. E ne sono contenta, per quanto poco questo possa valere.
La grandezza di questo artista, schivo e certamente poco avvezzo alla spettacolarizzazione, é difficile da raccontare, tanto quanto possa sembrare scontato a tutti quelli che ne hanno seguito il percorso artistico e lo hanno amato. É apparentemente un personaggio che appartiene più alla generazione dei nostri genitori che a noi, ma come tutti gli artisti che creano davvero qualcosa, che modificano o plasmano una direzione che altrimenti non sarebbe esistita, non c’è appartenenza diretta: siamo tutti più o meno fortunati eredi.
Vorrei che tutti lo avessero conosciuto e capito come i “napoletani” o giù di lì. Non solo perché è stato il più grande bluesman d’Italia, l’unica voce e l’unica anima capace di far battere le mani a tempo di blues agli italiani, da sempre romantici ascoltatori melodici.
Non solo perché è stato un artista e un ascoltatore eclettico, capace di spaziare dal blues al funky e al jazz, coniugando queste passioni con la tradizione napoletana. Non perché ha suonato e collaborato con grandi maestri internazionali (come Eric Clapton e Pat Metheny, o Billy Cobham, Wayne Shorter, Rachel Z, Chick Corea e Gato Barbieri) o perché ha fatto tourné e concerti memorabili.
Ma sopratutto perché era poetico, non cercando neppure di esserlo. Lo era davvero. E dei tantissimi artisti italiani in circolazione, a trovarne uno veramente poetico, bisognerebbe andare in giro con un lanternino.
Perché ha scritto versi come “Mitt e criatur o sole, perché hanna sapè arò fa fridd e arò fa chiù calor” (Metti i bambini al sole perché possano distinguere i posti in cui trovare calore da quelli freddi). Perché ha saputo mixare l’italiano, il napoletano e l’americano con una naturalezza tale che a volerlo fare d’ingegno non ci si sarebbe riusciti così bene. Perché ha scritto una canzone che parla di dolore e insofferenza e l’ha intitolata “Alleria” (Allegria).
Ma Pino, ha avuto una capacità su tutte: raccontava la napoletanità e la spiegava come se fosse una cosa semplice, senza scadere nel folklore e nelle immagini stereotipate, ma piuttosto attingendo alla poesia e alla creatività. Ha cantato i vizi e l’indolenza dei napoletani, con l’autoironia che solo questi conoscono.
E poi c’é che mi fa ricordare di me alla fine delle scuole superiori, quando in macchina suonava sempre questa, che mi sembrava la cosa più moderna che avessi tra le mani e mi metteva in testa che esplorare il mondo del funky e del jazz sarebbe potuto essere una cosa quanto meno carina:
Di tutto quello che non ho potuto o saputo dirvi, spero che abbiate voglia di cercare, c’è davvero tanto da ascoltare. Da conservare, suonare, raccontare ancora.
Intanto grazie, a Pino Daniele, che la musica l’ha fatta davvero.
Per tutta la bellezza che ci ha lasciato.
Articolo scritto e redatto da Alessia Esposito | Tutti i diritti sono riservati