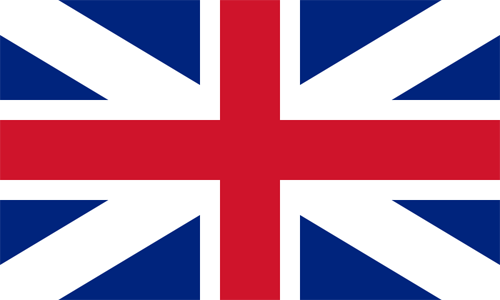A volte vorrei avere la forza di certe donne che vivono il loro corpo completamente, sotto ogni aspetto, in ogni modo. Non hanno paura di lesinarlo, consumarlo, stancarlo. Lo vivono e basta, come un involucro che permette loro di fare mille cose senza neanche pensarci, senza che un solo pensiero attraversi la mente.
A volte vorrei essere così, invece mi risparmio. Non risparmio energia o forze, risparmio l’esterno, come se avesse poca importanza.
Quando ero giovane lo davo per scontato, quasi l’esterno neanche lo vedessi, adesso con il passare degli anni inizio a vedere la vita che si disegna su alcune forme, su alcune porzioni di questo corpo che mi è così familiare, ma al contempo così estraneo.
È strano non conoscere il proprio corpo, non averlo preso in considerazione per tanto tempo. Pensare che tanto è lì, che ci sarà tempo, che alla fine condividere l’esistenza significa anche un po’ conoscersi. In realtà non c’è nulla di più sbagliato. Non l’ho mai trafitto con piercing, non l’ho mai disegnato con tatuaggi, l’ho lasciato praticamente invariato, immacolato, dando la possibilità soltanto alla natura e alla forza di gravità di imprimere modifiche su di esso.
Poi però sono arrivate le operazioni, non desiderate, ma necessarie.

Il taglio cesareo gemellare per dare vita alle mie bambine, l’addomino plastica per sistemare quello che la gravidanza aveva lasciato erroneamente, un taglio alla gola per togliere una paratiroide. Tre segni, indelebili sulla mia pelle: i tatuaggi che non ho mai avuto, i segnali di quello che ho passato. Oggi, con una consapevolezza tutta nuova, mi guardo e li vedo. Praticamente vedo più questi tre segni, che tutto il resto.
Non li volevo questi tre segni. Anzi, il primo sì: il primo è sempre stato un segno di grinta, di vita, di desiderio, di maternità. Con quel primo taglio ho dato la vita non a una, ma a ben due persone che quotidianamente animano la mia esistenza di gioia, scoperta e purezza. Non tornerei mai indietro, non rinuncerei mai a questo primo segno: se fosse per me ne parlerai ogni giorno, perché dimostra quanta forza era racchiusa dentro di me.
Il secondo non lo volevo, ma è arrivato per necessità. La gravidanza aveva reso la mia pancia troppo grande, i miei muscoli non dialogavano più fra di loro, c’è stato bisogno di un chirurgo per rimetterli uno vicino all’altro, per chiudere una diastasi di nove cm e ridare alla mia pancia una forma accettabile. È stato un intervento lungo e faticosissimo, con un post operatorio tremendo. Sono diventata dipendente da mio marito per quasi sei mesi, con un’infinita paura c he i punti potessero cedere, che dovessi tornare in sala operatoria, che quella decisione di non inserire una rete contenitiva potesse rivelarsi errata. Se ci penso ora, dopo tre anni, mi sembra sia passata una decade, quasi non ricordo il dolore, il fastidio, la mal sopportazione di un’operazione così profonda. Un’operazione che mi ha fatto diventare insensibile alle carezze, all’acqua, alla sensazione dei vestiti sulla pelle e che solo adesso, dopo anni, inizia ad attenuarsi.
Poi, nell’anno più nero dell’esistenza globale, chiusa in casa fra un lockdown e l’altro, senza la libertà di viaggiare, scoprire e muoversi ho iniziato a stare male di nuovo. Dopo alcuni mesi è arriva la diagnosi: iperparatiroidismo primario. Un adenoma aveva pensato bene di scegliere il mio corpo per la sua vita, così, a inizio 2021 lo abbiamo rimosso con un taglio orizzontale, che segue una piega del collo. Lì, dove passa l’aria e il sangue, dove il cibo diventa nutrimento, dove la voce prende corpo: hanno tagliato proprio lì. Entrare in ospedale da sola, rispettando tutte le normative anti Covid, è stato tremendo, doloroso e difficile. E nonostante l’operazione sia andata bene e la dimissione sia stata velocissima, sarà difficile dimenticare la sensazione degli ospedali silenziosi, ma al contempo pieni di pazienti, ciascuno chiuso nei propri pensieri, a distanza, nascosto da una mascherina che gli cela metà viso.
E così siamo arrivati fino a qui, a questi tre segni sul corpo, tre segni che non ho deciso io per forma, posizione e tempistica. I miei primi tatuaggi, quelli che mi ha fatto la vita, quelli che mi ricordano ogni giorno le difficoltà che si possono incontrare, che si devono accettare e affrontare, perché bisogna passarci attraverso alle cose e alle situazioni per lasciarle nel nostro passato. Sono cicatrici: tre cicatrici di diversa fattezza, ma di medesimo ricordo: il ricordo della forza che ho dentro di me, quella forza che non pensavo di possedere, che temevo non facesse parte di me invece, nel momento del bisogno, si è palesata ed è diventata padrona delle mie azioni, delle mie decisioni.
Eh sì, a volte invidio quelle donne che riescono a vivere il loro corpo nella loro completezza, incuranti delle necessità – o degli intoppi – che la vita potrebbe, ad un certo punto, inaspettatamente, mettere dinanzi. E forse da questa riflessione imparerò qualcos’altro, ad amare di più questo involucro fisico, fatto di pelle, sangue e tanto altro che, ogni giorno, mi dà la possibilità di vivere, di respirare, di scoprire, di imparare, di confrontarmi, di amare, di ricevere amore. No, non penso che stiamo parlando solo di un corpo, ma di qualcosa di più, una porzione di spazio nel mondo destinato a noi, e solo a noi, di cui dobbiamo prenderci cura, perché senza di esso non esisteremmo noi.